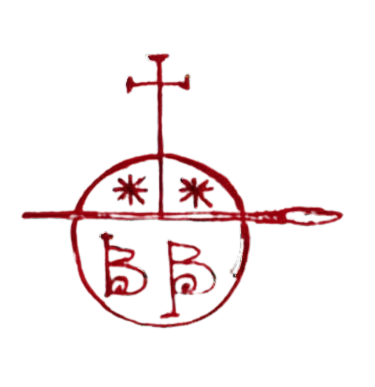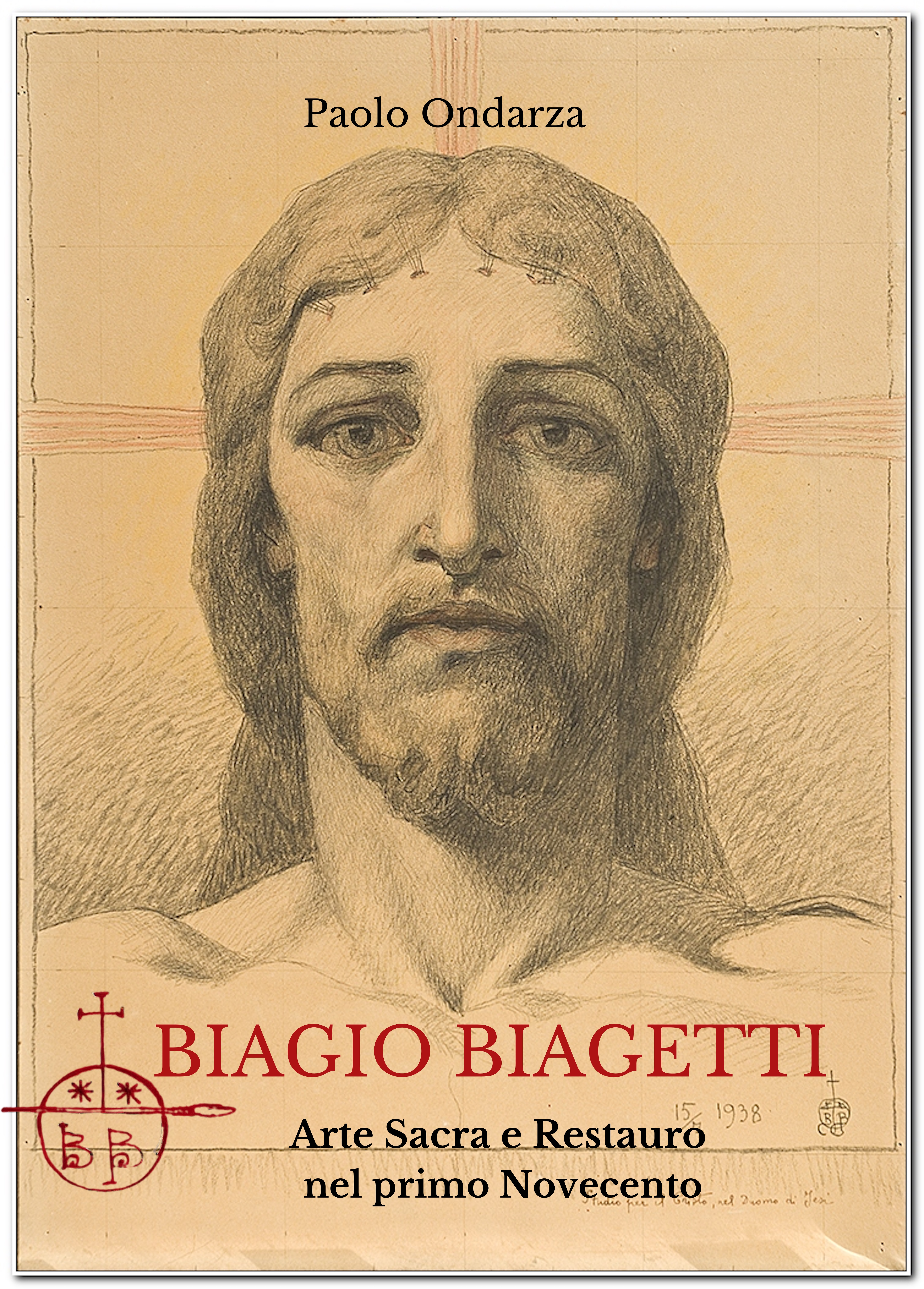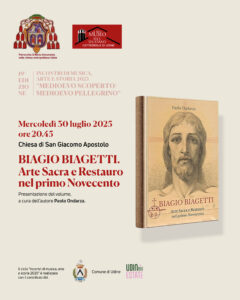Continuano le iniziative in occasione dei 700 anni dalla nascita, ad Arezzo, di Francesco Petrarca, grande maestro della letteratura italiana di fine Trecento. In particolare i Musei Civici agli Eremitani di Padova, dove il letterato soggiornò dal 1368 fino alla sua morte nel 1374, accolgono la mostra “Petrarca e il suo tempo”. L’esposizione, aperta al pubblico fino alla fine di luglio, riunisce circa 170 opere, tra cui splendidi codici miniati provenienti dalla Biblioteca Nazionale di Parigi ed il prezioso manoscritto 3196, probabilmente il più importante della lirica italiana, eccezionalmente concesso dalla Biblioteca Vaticana. Sulla figura dell’autore del Canzoniere ascoltiamo il servizio di Paolo Ondarza:
Spirito eletto del Trecento italiano, Francesco Petrarca aprì le porte in Europa a quella riscoperta, divulgazione ed esaltazione dei testi della latinità, che ridestò in tutto il continente l’amore per la lezione civile, etica ed estetica dell’antichità classica, precorrendo la straordinaria stagione dell’Umanesimo letterario.
Nasce ad Arezzo da ser Petracco ed Eletta Carnigiani. La famiglia si trasferisce ad Avignone e Francesco ha la possibilità di iniziare lo studio delle materie giuridiche nella vicina Università di Montpellier, per poi proseguire a Bologna. Nel capoluogo emiliano conosce Cino da Pistoia e da lui scopre l’amore per Cicerone e per la poesia e filologia classica sviluppato nel suo soggiorno a Padova. Dopo la morte del padre, Francesco è emotivamente toccato dall’entrata del fratello Gherardo, compagno di divertimenti mondani, nell’Ordine dei certosini. Sono anni densi di riflessione interiore su cui irrompe l’incontro, dentro la chiesa di santa Chiara, con la donna che sarebbe divenuta l’ispiratrice di tutte le sue liriche: Laura. E’ il Venerdì Santo del 1327:
Erano i capei d’oro a Laura sparsi,
che in mille dolci nodi l’avvolgea
e il vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi …
La natura inquieta dell’uomo, la curiosità mai sazia dell’intellettuale, la fervida passione politica del diplomatico, condussero il poeta a viaggiare e a frequentare le più raffinate corti europee. Entrò, sembra, come cappellano al servizio della famiglia Colonna. E’ il periodo degli esametri dell’Africa, dei componimenti allegorici del Bucolicum Carmen, delle biografie De viris illustribus, le Epistole metricae, i trionfi e le rime di carattere prettamente psicologico.
In vecchiaia prevalse in lui il desiderio di quiete e di raccoglimento che lo condusse alla tranquillità dei colli Euganei per ritrovare quel paesaggio dell’anima che gli permise di dedicarsi con serenità, fino alla morte, agli studi e alla poesia. Il Secretum raccoglie le più sincere confessioni e costituisce il momento culminante della crisi religiosa del poeta, a cavallo tra ascesi medievale e fiducioso ottimismo rinascimentale. Seguono i soliloqui del De vita solitaria, De otio religioso e De remedis utriusque fortunae. Il senso della vita, la felicità e l’esaltazione della solitudine come strumento di libertà ne sono i temi portanti.
Il conferimento dell’alloro poetico nel 1340 ha eternato il nome di Francesco Petrarca rendendolo vivo anche oggi a distanza di sette secoli. Sull’attualità dell’opera del poeta diamo la parola a Giulio Ferroni, docente di Letteratura italiana all’Università La Sapienza di Roma:
“Viviamo in un tempo di frantumazioni infinite, di sperimentazioni linguistiche. Una grande poesia come questa può ricordarci ancora oggi l’essenzialità del valore di una dizione delle cose della vita e dell’esperienza che miri a qualche cosa di assoluto”.
E se la storia della letteratura pone Petrarca nell’ambito del Medioevo, un abisso generazionale lo separa dall’epoca di Dante e lo pone in colloquio con la successiva produzione letteraria confinata convenzionalmente nell’ambito del Rinascimento.